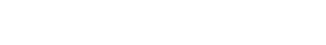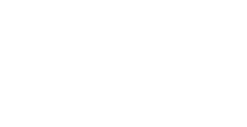ZIO CESARINO
ZIO CESARINO
Quando muore qualcuno i parenti hanno sempre il problema di trovare la fotografia giusta da mettere sulla lapide al cimitero, magari non troppo allegra e non troppo triste, con il vestito della festa. Mi son sempre chiesto se qualcuno di loro avesse mai pensato, al momento di farsi fotografare, a cosa quella foto sarebbe un giorno servita.
Quando è morto lo zio Cesarino problemi proprio non devono averne avuti perché la sua foto è così bella, serena, “giusta” che non potevano farne una uguale.
Sotto il cappellaccio di paglia un po’ schiacciata c’è un sorriso, un’arguzia, una serenità che penso colpisca tutte le persone che hanno la fortuna di passare per il cimitero dell’Isola.
Quando bambino andavo all’Isola non potevo seguire le barche grandi alla pesca perché partivano la sera e tornavano solo il mattino dopo ed uscivano con qualsiasi tempo a inseguire coregoni e trotelle da Ghiffa in su verso la Svizzera, mentre zio Cesarino invece usciva solo al mattino di oslito verso le cinque ed un mucchio di volte mi portava con lui. Anni dopo, ormai esperto, promosso mozzo di fatica sulle altre barche (paga 1.500 lire oltre alla cena al ristorante Viaggiatori di Oggebbio, due quintali di bondelle da pulire, posto-barca in sacco a pelo con sveglia all’una di notte che sembrava di esserti addormentato due minuti prima) tornando dalla pesca “grossa” lo vedevo ancora uscire ancora a quell'ora con l’Augusto, sempre a remi.
Le cinque sono, sulla fine dell’estate, un’ora tutta particolare: il lago a settembre non è limpido ma sfuma in una bruma sottile che si scioglie verso mattina.
Lo zio prima andava alla punta del Verbano “a sentir l'aria” e vedere il tempo, masticando una pagliuzza. In quei momenti non è più notte, ma neppure giorno: le stelle sono spente ma i lampioni sulle rive resistono ancora e solo allora lo zio Cesarino mollava appunto gli ormeggi per la piana di Fondotoce.
La barca davanti all'isola andava a remi, lentamente, “per non svegliare nessuno” e solo passata la coda lo zio prendeva una vecchia bottiglia di vetro dell’olio Dante (ce n’era una di riserva ma era della spuma Giommi) con dentro la miscela per il motore e – con un imbutino di latta - la versava nel serbatoio.
Tirando una corda arrotolata sulla ruota d’avviamento faceva partire il motore (verde, con la scritta “Marine”) che dopo qualche tentativo a vuoto di solito si avviava scoppiettando e tossicchiando fino a prendere il ritmo giusto e, con un remo a far da timone, di solito si andava appunto verso i canneti o lungo la riva di Baveno.
Lo zio Cesarino non sopportava la pesca di quantità, quella delle reti volanti in mezzo al lago “dove il pescatore aspetta solo che i pesci passino di lì e poi tira su tutto” ed aveva la “sua” pesca, quella specifica, misurata ma di qualità. Mezza cassetta di persico, due di arborelle, le tinche e le “butrise”, qualche luccio o la trota - ma solo se dal chilo in su - pescata però dove “doveva” esserci.
Era una pesca attenta e precisa di chi sapeva tutto dei fondali e delle correnti seguendo il ritmo naturale e tranquillo di un lago che ogni anno inseguiva il correre delle stagioni.
Quando (a quindici anni e un giorno) ebbi in tasca la licenza “da professionista” e quindi potei mollare la canna da pesca per qualcosa di più serio, la nonna Olga mi regalò tre tramagli (13 mila lire l’uno) che con trepidazione la prima volta “misi giù” al largo di Villa Aminta, verso Stresa, ancora bianchi perchè nuovi di pacca e neppure tinti tanta era la voglia di non perdere neppure una notte.
Una settimana dopo lo zio Cesarino cominciò a indicarmi dei posti giusti e – visti i progressi – dopo qualche settimana mi ricevette nel “suo” deposito in riva dietro, in una cantina tra mucchi di reti da sistemare e pescò su due tramagli e due realini speciali (“sono usati, ma vanno benissimo”) e da quella volta mi misi in proprio…
La mia barca si chiamava “La corsara” perché aveva lavorato per vent’anni a fare la spola per il ristorante “la Piratera” dell’Isola Madre. Venne via, motore Evinrude da cinque cavalli compreso, per 100 mila lire del 1967. Giravo il lago e dormivo in barca, nelle darsene, al molo, dove capitava: una volta mi svegliò il guardiapesca Galli all’Isola Madre: era ormai giorno fatto e attraccata la barca con tutti i crismi di sicurezza ma stanco morto, mi ero addormentato in piena notte sul fondo nonostante il temporale.
Penso che a casa mamma stesse un po’ in pena quando tuonava o tirava vento ma sapeva che mai avrei fatto colpi di testa: il lago chi lo conosce lo teme e non lo prende mai sottogamba.
Solo una volta mi prese in contropiede: era il 7 luglio del ’71 e verso sera con l’Angelo Cattalani mettevamo le reti alla “Cà dai Ladar” tra Intra e il Sass Galet. In pochi istanti e a ciel sereno fu una bolgia di vento, di fulmini, di onde che - da fuori - nessuno crederebbe possano esserci in un lago come il nostro.
Eravamo a cento passi da riva, ma toccammo terra solo tre chilometri più giù, infilandoci a tutta birra nella foce del torrente San Bernardino e - se cento volte ho passato la notte con il vento o l’acqua a catinelle - non fu mai come quella.
Ma queste sono cose del “dopo”, torniamo allo Zio che soprattutto mi insegnò (“ecologista” ante marcia) che il lago ha le sue regole, i suoi limiti, che non è una dispensa infinita e che quindi va trattato con parsimonia e rispetto.
Mi insegnava a lanciare la “tramagina”, a riordinare le reti, a pulirle ed anche a rammendarle, ma questo senza fortuna perché già allora tenermi fermo con il filo in mano era un dramma.
Poi, pian piano, lo “svezzamento”: “Stasera vai tu al largo di Villa Castelli, al Lido di Carciano. Ascolta: ci sono due mucchi di pietre sott’acqua e la rete devi metterla giù adagio, con calma, senza tirarla: non importa se non arrivi fino in fondo, la rete deve “lavorare”, deve potersi tendere solo quando il pesce ci entra e che non deve rimbalzare inhdietro.
Un concetto che cercherò a mia volta, quindici anni dopo, di spiegare ai pescatori Ol Molo sul lago Turkana - che posavano le reti di palma quasi fossero quelle di un campo da tennis – quando per un po' mi trasferii nella sperduta missione di Loyangallany (nel nord del Kenya) a conoscere e vivere il terzo mondo in diretta.
“Attento, allora, quando batti coi remi, devi far rumore sotto ma non picchiare troppo o ti riempi di piotte (le scardole, pesciacci che non valgono niente e spaccano le reti). Vedrai, lì è la casa delle tinche…”. Ed era vero.
Un’altra volta mi aveva spedito al largo della “coda”, verso Baveno, con in barca solo un pezzo di rete, spiegandomi bene dove ne avrei preso una grossa. C’era (cinque chili e due etti!) la mattina dopo e io - che avrò avuto un dodici anni, non di più - feci tutto il giro dell’Isola camminando sul lungolago gonfio d’orgoglio con il mio trofeo. Al Verbano, dove stata sistemando la barca, soddisfatto gliela mostrai.
“Stupìd!” mi disse, e continuò a buttar fuori acqua con il palotto.
Non capii… ma compresi la sera, quando il “mio” posto era occupato da tante reti della concorrenza, e addio sorpresa (e tinche) per il resto della stagione.
Imparai che il pescatore vero tace e non si mette mai in mostra,anzi, meglio dire che non si pesca mai niente. “Zio - gli dicevo - ma perché metti delle reti del 45 (millimetri di lato per maglia, serve per pesci grossi) anziché del 30, che ne prenderesti di più?
“Perché le trote vere le prendi solo con queste, le altre reti fanno da muro, e si spaccano…”. Così tante volte si lavorava per niente, ma quando arrivava la trota era grande da togliere il fiato…
E poi quella volta sul far del mattino alla piana di Fondotoce, quando si pescavano arborelle con l’Augusto in acqua bassa, spingendole verso le reti (i “realini”) con un gran lavorio di remi
Si fermò un po’ al largo un grande uccello bianco e nero, bellissimo. Non so cosa fosse, ma qualche minuto dopo dal canneto uscì zitta zitta una barca bassa, una spingarda con mimetizzato sopra un cacciatore.
Si avvicinò e stava per tirare il colpo quando - fulmineo - zio Cesarino sbattè violentemente i remi in acqua e l’uccello volò via, levandosi lento lento verso il cielo come un idrovolante.
Il cacciatore, imbestialito, puntò il fucile su di noi e fu un sventagliata di pallini per aria che per fortuna non fecero male a nessuno. Tutti, in barca, “tifavamo” per l’uccello salvato ma - mi dicevo - in fondo anche noi siamo come i cacciatori a pescare persici e tinche con tutte le diavolerie organizzate. “Sì, ma non dobbiamo divertirci mai nel vedere un animale che soffre, replicava lo zio, e quando ne abbiamo abbastanza bisogna smettere, subito…”.
Poi, un giorno, la sua barca non uscì più perché il Domenico era malato e qualche anno dopo, un pomeriggio di gennaio, arrivò a Pallanza la notizia che anche lo Zio Cesarino aveva preso il largo, ad 80 anni suonati.
Presi trafelato la barca da pesca del Togna perché a gennaio di battelli ce ne sono pochi (ma - senza turisti - sono una cosa seria) e corsi all’Isola a tutto gas. Scendeva limpida la sera invernale quando arrivai. Lo zio - mi spiegarono - dopo pranzo aveva iniziato a scrivere un appunto, senza occhiali ed in bella calligrafia. Si fermò dopo la data: “5 gennaio 1977”, poi reclinò il capo e disse solo una parola: “Signur!”.
Al camposanto dell’Isola adesso sta di fianco all’Augusto e forse al mattino si ritrovano ancora a dieci passi da lì, sul molo del Verbano, a vedere lo spettacolo delle prime luci verso Santa Caterina. “Marca vento, ma in alto” commenterà lo zio con le gambe larghe e le mani dietro la schiena, uno stecchino in bocca e il cappello di paglia in testa. “Alùra, andem…” risponderà l’Augusto, avviandosi al porto mentre le stelle si spengono una per una e l’ultima neve, lassù sul monte Zeda, comincia a cambiare colore per il giorno che viene.