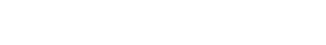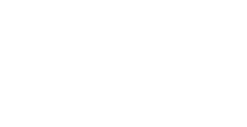DON GIUSEPPE E QUEL SEMINO DI VITE...
Interventi
Dal
libro LA MOSCHERUOLA di Marco
Zacchera – Alberti libraio ed. – 2015
DON GIUSEPPE E QUEL SEMINO DI VITE...
Questo testo è la prefazione di un
libretto mai nato. Mi era stato chiesto di scriverlo perché fosse parte di un
libretto-regalo ai pallanzesi per l’85° compleanno di Don Giuseppe Masseroni,
ma poi non se ne è fatto nulla e allora ho pensato di inserirlo qui e non tanto
per i verbanesi che lo conoscono bene, ma per i lettori più lontani che
probabilmente non l’hanno mai visto né conosciuto. La ragione è speciale: Don
Giuseppe ha una sua storia di cristiano da raccontare a tutti proprio perché a
tutti ha dato e può dare una mano, soprattutto nei momenti di difficoltà e di
bisogno. Non solo lui personalmente ma per la speranza che rappresenta e la sua
capacità di stare vicino. E’ appunto un “semino” che ha attecchito a Pallanza
ma poteva essere piantato ovunque: il soffio dello spirito va dove vuole e
entra nel cuore degli uomini con le persone e le forme più diverse. Così, quando si dice “testimoni del tempo”
eccone uno…
Raccontare
di Don Giuseppe Masseroni ti porta subito a sorridere ed è piacevole anche
perchè diventa una bella l'occasione per cucirgli intorno ricordi di un' intera
città che è cresciuta con lui rispolverando così episodi, persone ed immagini
che vorresti non fossero dimenticate da chi verrà dopo di noi nella ruota del
tempo.
D’altronde se conosci un sacerdote che comincia il suo
ministero proprio quando tu ti affacci alla vita e resti in contatto con lui
per decenni alla fine la storia che ne viene fuori è facile, semplice e
immediata, ma stretta come quella delle
viti che riempiono gli angoli dei giardini.
Piante
non forzate nel loro sviluppo come quelle dei filari diritti sulle colline e
pronti per la vendemmia, ma come quelle viti un po' strane e contorte,
solitarie, quelle che all'inizio crescono quasi per caso tra due sassi - tanto
che le fai appoggiare a un bastone per non farle cadere - ma poi loro prima o
poi si agganciano da sole a un pilastrino o una tettoia e si mettono a correre
su per i balconi e le finestre. Anno dopo anno diventano tutte rugose,
attorcigliandosi sulle verande delle nostre vecchie case verso il lago. Così,
senza cure particolari, ogni estate prima ti fanno una bella ombra poi diventano la gioia di chi va a
rubacchiare i grappoli tra le foglie quando cominciano a diventare gialle
mentre gli ultimi acini fanno da dispensa autunnale per un battaglione di
quelle vespe che sanno sempre scegliere il meglio.
Eppure
nessuno, all'inizio, aveva pensato di impiantare proprio lì quell’uva nata da
un seme che probabilmente qualcuno aveva sputacchiato per terra insieme alla
buccia di un acino.
Quel
semino è però germogliato tutto da solo, nel silenzio, ma giorno per giorno è
cresciuto – come i semi delle piante di sesamo che da
duemila anni in qua si sono fatti una grande pubblicità con le parabole del
Vangelo – ed è diventato una grande pianta capace di affrontare il gelo, il
vento e i temporali...o i guai della vita come è stato per Don Giuseppe a
Pallanza.
La
similitudine dell’uva – ma solo dopo che
l’avevo già scritta – mi ha riportato con il pensiero in Piazza San Pietro in
quel giorno di aprile del 2005 in cui la TV aveva appena mostrato la fumata
bianca dalla Cappella Sistina e così, lasciata Montecitorio per un’oretta, con
tanti colleghi eravamo andati in piazza per vivere l'attimo storico e sentire
in diretta chi fosse entrato in conclave cardinale uscendone papa e - quando
Benedetto XVI uscì a benedire dal balcone
della basilica – anche lui subito aveva parlato di sé stesso come di un povero
operaio piantato nella vigna del Signore.
Don
Giuseppe per ora non l’hanno ancora fatto papa (ma non si sa mai, non ci sono
limiti per lo Spirito Santo…) ma è stato sicuramente un semino di uva solitario
trapiantato a portar frutto in quel di Pallanza. Ma in fondo i “Masserùn” sono
agricoltori da secoli, quindi nulla di nuovo sotto il sole.
Le
similitudini agricole finirebbero qui, se non avete mai avuto l'occasione e la
fortuna di passare in quel di San Leonardo scoprendo il giardino nascosto della
canonica, quella che – ma lo sanno in pochi – era mille anni fa il castello dei
De Castello e dei Barbarava, famiglie nobili della “bassa” (probabilmente di
Biandrate) che aveva infeudato Pallanza. Un giardino piccolo piccolo, quasi
pensile, nascosto tra le case e fatto di poche aiuole e piante da frutta, ma
perfettamente esposto al sole del lago e che Don Giuseppe per anni ha curato
nei (pochi) tempi liberi tra un impegno e l'altro.
Mai
notata l’antica porta del castello verso la nuova via recentemente dedicata al
prof. Andrea Cavalli Dell’Ara e già Via Prevostura? Quel prezioso arco di
granito era la porta carraia di un castello grande come oggi sono le case
davanti alla chiesa, probabilmente con il lago intorno (allora il livello era
un po’ più alto di adesso), una penisola o un’isoletta tipo quella di San
Giovanni che infatti sta a poca distanza, probabilmente un'altro scoglio della
stessa, antica morena glaciale.
Ma
torniamo al personaggio di questo libro o ci allarghiamo troppo...
Dunque,
nel settembre del 1949 arrivò a Pallanza un “prete novello” come si usava dire
allora (oggi di “Novello” è rimasto solo il vino nuovo a novembre, ci
ricaschiamo con la vigna…) spedito a Santo Stefano, su in “Vila”.
Lui
probabilmente non immaginava che a Pallanza ci sarebbe restato per sempre, come il semino d’uva che una volta fatte le
radici non lo sposti più, fatto sta che cominciò subito con impegno a lavorare
con i ragazzi dell’oratorio (allora a Pallanza
di parrocchie e di oratori ce n'erano due, anche se il Don Bosco in
fondo era solo a due passi). Don Giuseppe lavorava con la gente più
semplice dimostrando subito una
attenzione particolare a chi si trovava in difficoltà.
I
Masseroni erano e sono gente di Fontaneto d'Agogna, terra di preti, fatica e
stentato granturco, e infatti in famiglia oltre a Don Giuseppe c’è ancora il
“coscritto” cugino Don Carlo (il missionario che sta in Burundi), Mons. Enrico
Masseroni arcivescovo di Vercelli (insomma, quello che ha fatto carriera) e don
Giancarlo che - dopo una vita in Africa e una breve comparsata a Cambiasca - è
attuale parroco a Santa Cristina di Borgomanero. Anche un altro fratello di Don
Carlo ha fatto vita religiosa, parroco a Bellinzago e un altro cugino – Don
Eugenio – è da una vita parroco in Valsesia mettendo insieme, insomma, una di
quelle che a ragion veduta si potrebbero classificare come “famiglie
benedette”.
Eppure
allora non era facile diventare sacerdoti: vocazioni numerose (spesso era anche
un modo per le famiglie povere di poter far studiare i figli) ma c'era anche
una dura selezione visto che l'anno in cui Giuseppe entrò in seminario in prima
ginnasio c'erano 85 chierici, ma gli ordinati furono poi solo 19. Tra questi
ben quattro di Fontaneto d'Agogna di cui tre con cognome Masseroni: record
insuperato ed insuperabile dopo anni di studio e – soprattutto nei gelidi
edifici del seminario all'Isola di San Giulio – tante privazioni all'insegna
delle “tre effe” (fame, fumo e freddo) che scoraggiavano più di un postulante.
Il
nostro Don Giuseppe tenne duro, ma era figlio unico e a casa non credo che
siano stati troppo contenti quando seppero della sua scelta, anche perché
venivano a mancare due buone braccia per i campi, ma la vocazione non mancava e
quindi “sia fatta la volontà del Signore” . Le prime esperienze del nostro don
furono da “prete operaio” su e giù con il treno della linea Novara-Domodossola
nell’inedita formula di fare il cappellano stando vicino ai pendolari delle
fabbriche, poi l'incarico a Pallanza che sarà la sua prima (e unica)
destinazione stabile.
Don
Giuseppe fu dunque insediato a Santo Stefano nel settembre del 1949 e ci si
trasferì con i genitori che avevano ceduto casa e terreni di Fontaneto agli
altri fratelli, ma purtroppo il primo maggio del '50 il papà di Giuseppe morì
improvvisamente a soli 59 anni e con lui rimase solo la mamma, scomparsa nel
1981.
Parroco
di Santo Stefano era al tempo Don Angelo Bona (che sarà poi prevosto a
Domodossola), un tipo sveglio che aveva raccolto intorno a sé - anche durante
la guerra - ragazzi in gamba e di carattere. Il “pretino” Masseroni venne
notato a Novara e presto delegato nella nuova realtà di San Bernardino e
Sant'Anna, un quartiere operaio allora territorio di Santo Stefano. Una
parrocchia da metter su tra i palazzi popolari che cominciavano a crescere
correndo dietro al boom delle fabbriche e soprattutto della Rhodiatoce poi
Montefibre, la grande e incombente fabbrica-città gonfiatasi fino a quasi 5.000
dipendenti ma poi finita come si sa). Una parrocchia tutta da inventare, a cominciare dalla
chiesa…che non c’era.
Ne
verrà poi su una fatta tutta di legno, più baracca che basilica, ma immagino
che lavorando a metterla in piedi c’era
già tutto lo spirito di don Giuseppe, missionario e carpentiere mancato.
Ad
essere sinceri missionario e carpentiere mancato mica tanto visto che soggiorni
di lavoro in Burundi ne ha fatti tanti e artigiano in fondo lo è sempre stato
(e continua ad esserlo) perchè dategli un attrezzo in mano e tirerà fuori
manualità insospettate.
La
formula ottimale per lui sarebbe stata insomma quella di prete e
carpentiere-missionario e infatti quando Giuseppe arrivava a Rwaranbgabo (diocesi di Ngozi, Burundi, dieci
chilometri dal Rwanda, appena su dall'equatore ) non faceva tempo a metter giù
la valigia (meglio sarebbe dire l'officina, perché si muoveva con trapani,
utensili ed attrezzature al seguito) che partiva a costruire scuole, aule,
dispensari e poi panche, porte, travi, costruzioni: mai a tirare il fiato.
Anche
la domenica pomeriggio, mentre il cugino don Carlo cercava di sentire in
diretta alla radio le disavventure dell'Inter (per decenni “Tutto il calcio
minuto per minuto” è stato uno dei pochi contatti con l'Italia per tanti
emigrati) il Giuseppe come minimo sistemava una porta, una serratura, lo
scarico della doccia.
Un
pensiero a vivere stabilmente in terra di missione don Giuseppe deve averlo
fatto di sicuro ma c'erano una mamma da curare, mille impegni, responsabilità e
quindi il viaggio in Africa si doveva sempre rimandare tanto che i soggiorni in
Burundi più o meno lunghi arrivarono solo anni dopo, quando uno avrebbe potuto
prendere l'aereo da Malpensa ed arrivare comodo a Bujumbura.
Ritorniamo
invece al 1957 quando il vescovo di Novara (che allora si chiamava Gilla
Vincenzo Gremigni, un tipo molto all'antica e formalista che – si dice – a
lungo sperò invano di diventare cardinale) chiamò Giuseppe a reggere la
parrocchia in un’ area della città che (gli altri) dicevano essere “un covo dei
rossi”.
Qui
bisogna spiegarsi: gli anni '50 dell'altro secolo erano un po' diversi da
quelli di adesso e quindi non erano facili a Verbania, come ovunque, i rapporti
tra la chiesa e il mondo della fabbrica e del sindacato – che controllava anche
l'amministrazione cittadina - distanti
spesso mille miglia da quello “bigotto e clericale” (la definizione era, come
sempre, quella degli altri) costituito della struttura cattolica nella sua rete
di parrocchie ed associazioni “bianche”.
Ma
Giuseppe era già allora un tipo speciale, pieno di risorse e ci mise poco a
fare amicizia con tutti, integrandosi pienamente con quel mondo difficile e
fatto soprattutto di (allora) recente immigrazione prima dal Veneto e poi da
Spinazzola, Ripacandida e dagli altri centri del sud che hanno dato linfa alla
nostra città, mentre non mancavano lotte operaie e contrapposizioni a volte
profonde.
Ero
troppo giovane per ricordarmelo, ma lo immagino a visitare la gente, prodigarsi
per trovare lavoro, sistemare famiglie, visitare l' ospedale, dare una mano a
tutti magari chiedendola anche al cav.
Pietro Della Rossa che – come esponente DC, ma soprattutto responsabile delle
assunzioni alla Rhodiatoce – poteva avere in mano il futuro di intere famiglie.
Intanto
a Santo Stefano divenne parroco don Girolamo Giacomini, spedito a Pallanza
sostanzialmente per punizione dal vescovo di allora perché troppo progressista
e spesso su posizioni di aperta rottura con la gerarchia, un toscanaccio pieno
di cultura e di idee nuove, di cristianesimo profondo e attento ai pensatori
più innovatori. Don Giacomini ci mise poco a creare intorno a sé un gruppo di
sacerdoti sempre più inseriti nella realtà sociale cittadina, aperti alle lotte
operaie.
Don
Giuseppe era uno di questi e San Bernardino rappresentava un punto di coesione
importante.
Venne
poi il 1966 quando lasciò la sua parrocchia, “promosso” a San Leonardo, un
viaggio di pochi chilometri ma in una realtà socialmente un po’ diversa e
parrocchia con diverse e antiche tradizioni non fosse che per avere alle spalle
almeno cinquecento anni di storia.
Mi
ricordo ancora il giorno del suo ingresso ufficiale: ero uno scout, il
caposquadriglia delle “tigri” e facevamo ala in divisa su per i gradini del
sagrato a questo nuovo prete magro e con i capelli neri, tagliati a spazzola.
“Sarò il prete di tutti, per tutti” disse nella sua prima omelia ed è stato
davvero così.
Erano
anni difficili in una città che cresceva velocemente, ma anche tra contrasti
nella stessa chiesa verbanese. Io non la pensavo come don Giuseppe su alcune
questioni, ma ricordo ancora un invito a cena che mio padre volle rivolgergli e
una lunga, affettuosa chiacchierata in salotto che mise in chiaro molti aspetti
controversi. Dentro di me rimasi colpito da un paio di concetti che mi furono
molto utili per “raddrizzare il tiro” e gliene sono ancora grato.
Anni
che corrono veloci: ne sono passati quaranta, e mi sembrano ieri. Cambiata la
liturgia e i segni dei tempi, cambiata la città che ha perso il suo slancio
propulsivo, invecchiati gli abitanti di una Verbania sempre più anziana,
invertito il flusso migratorio che ha portato a nuove realtà.
Oggi
non c'è più nemmeno quella chiesina di San Bernardino bruciata in un incendio
con Don Giuseppe che a fatica mise in salvo il Santissimo all'ultimo momento,
ricostruita più bella di prima, ma un po' meno “missionaria” perchè quella
povera struttura in legno assomigliava tanto alle chiese dell'Africa costruite
in fretta ai margini della foresta.
Anni
che corrono, ma in cui Giuseppe ha lavorato ogni giorno per tutti mettendo a
disposizione la sua vita per la nostra comunità condividendo con ciascuno di
noi tante occasioni liete e tristi.
Ha
visto nascere e morire, ha benedetto matrimoni e battesimi, ha chiuso gli occhi
a tante persone care.
In
questi anni anche don Giuseppe è cambiato e non solo perchè i suoi capelli da
neri sono man mano diventati bianchi, ma perchè ha assunto un tratto diverso,
più sereno e profondo, da grande maestro di vita. Quello che in lui non è mai
cambiato è stato piuttosto il suo desiderio di condividere con la gente le
difficoltà con aiuti concreti fatti di gesti utili e immediati, oltre che da un
sorriso.
Aiutare
la gente per un prete non è solo benedire ma appunto stare vicino, ascoltare,
consigliare e questo ben al di là dello stretto senso religioso, anzi, quante
volte le persone hanno ricorso a lui eppure non frequentavano la parrocchia o
non erano neppure cristiani.
E
allora l'amicizia diventa anche “fare”: quanti armadi aggiustati, traslochi,
letti recuperati? Aiutare è anche mettere a posto lo scarico di un lavandino a
un'anziana che da sola non ce la fa, guardare negli occhi immigrati che - specialmente qualche tempo fa
- arrivavano sgarrupati ed incerti, come gli albanesi che nei primi anni '90
scappavano in gommone e poi, arrivati in Italia, anche dai campi di
accoglienza.
Per
Giuseppe stare con la gente ha sempre significato sistemare case, salutare
tutti, dare un primo aiuto a chi usciva dal carcere. “Missione” è trovare un
letto e una minestra sui due piedi per chi non ce l'ha e questa disponibilità
totale è sempre stata la sua predica più bella, perchè era l'azione che
concretizzava la Parola.
Lo
potremmo definire un “Guru”, ma io lo chiamerei piuttosto buon esempio, fatto
di semplicità ed essenzialità per dare certezze, ma allo stesso tempo sposando sempre
di più l'immagine di una Chiesa aperta, essenziale, più povera ma pronta a
capire e perdonare. Una chiesa soprattutto vicina all' Uomo, con tutti i suoi
difetti ma anche sottolineando le sue grandi possibilità di crescita.
Una
filosofia della speranza, insomma, del non arrendersi mai, del perdono
profondo, dell'impegno senza riserve.
Spesso
- mentre viaggio in auto non solo stando attaccato al cellulare - risento su CD
le sue omelie della domenica (gliele hanno registrate di nascosto) che da anni
tiene a Santo Stefano e in quelle parole c'è appunto un grande messaggio che è
fatto di parole semplici, mani aperte, apertura mentale e spirituale a
sottolineare che sono le azioni del cuore quelle che contano più, non le
formule.
D’altronde
se il Signore si è fatto uomo come noi, ci conosce benissimo e quindi ci
capisce quando ci rivolgiamo a lui con tutti i nostri dubbi ed i nostri errori,
senza per questo dovere averne paura.
Le
prediche di Giuseppe sono belle anche perché calano la parabola o la liturgia
della domenica negli atti concreti, nei problemi comportamentali di ogni
giorno.
Risentendole,
stupisce che ci siano tante frasi che esprimono concetti e poi vengono lasciate
per aria, interrotte, quasi che debbano essere proseguite dal ragionamento di
chi ascolta perché da un certo punto in poi non è il prete a dover parlare, ma
direttamente la coscienza di ognuno.
Scrivendo
me lo vedo davanti e mi scorrono le immagini di un Giuseppe sempre in giro e
operativo, prima con uno scassatissimo “maggiolone” grigio Volkswagen, lo
stesso modello e colore di suo cugino Carlo in Burundi, scassato questo come
quello, che rimisi una volta in marcia sulla salita in terra battuta verso
Murehe con una corda al posto della cinghia di trasmissione e per questo venni
dipinto come provetto meccanico, invece è stata l'unica riparazione della mia
vita...
Ma
mentre don Carlo passò poi ad una Panda 4x4 don Giuseppe ha optato per la
bicicletta e così me lo rivedo, in bilico con materiale vario di trasferimento
al seguito, oppure fermo a un angolo di strada a parlare con la gente.
All'immagine sovrappongo il suo sorriso, la sua tranquillità di ragionamento e
di impegno, l'amicizia con cui ti accoglie magari in un confessionale.
Una
fede che costruisce speranza, ti allontana dalla disperazione, anno dopo anno
ti aiuta nella missione di affrontare i problemi con più calma ma meditando e
risolvendoli bene. Una fede che si trasforma quindi in riflessione, silenzi ma
rafforzando l'impegno verso gli altri che significa non arrendersi mai neppure
nei momenti più bui.
E
nel solco del ricordo emergono tanti visi, voci, personaggi di una Pallanza che
cambia come la vita. Dal sacrista-elettricista Gualdi alla mamma di Don Giuseppe
così dolce (e sempre anche lei a sistemare qualcosa), ai sacerdoti che si sono
avvicendati a Pallanza in questi decenni: tanti “don” da Piergiorgio a
Riccardo, a don Carlo con Gianni, Roberto e negli ultimi anni don Simone. Gente
che va e che viene mentre lui è sempre lì, “parroco emerito” come si dice
adesso.
La
vite piantata da Giuseppe è lui stesso ed è cresciuta, ha portato frutto, ha
messo radici, ha fatto crescere una comunità cittadina che ogni giorno è
chiamata a confrontarsi con le difficoltà ma che – se si volta indietro –
scopre di averne comunque superate tante.
Per
questo, nel momento in cui la nostra vita come quella di Don Giuseppe si avvia
ad un naturale tramonto, da quella comunità esce spontaneo un “grazie” che
diventa sorriso semplice, una mano aperta che non si chiude mai.
E'
un po' come in certi pomeriggi tiepidi quando anche a Pallanza l'ultimo raggio
di sole è già calato dietro il Mottarone ma le pietre del lungolago e delle
case sono ancora calde e riflettono il calore della giornata.
Ti
metti allora un attimo a guardare il lago da una finestra o da una panchina,
ringrazi per lo spettacolo stupendo che ti viene offerto e pensi alle persone
più care che quello scenario lo hanno condiviso con te.
Viene
spontaneo e facile dire una preghiera di “grazie” al Grande Capo per essere lì
a poter vivere la bellezza del momento, ma ricordando anche chi - nel Suo nome - nella vita ti ha dato una mano, perché
qualche volta il Signore sembra lontano e qualcuno invece ti è stato vicino.
In
quei momenti, in molti credo ricordiamo don Giuseppe.
MARCO
ZACCHERA