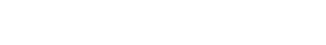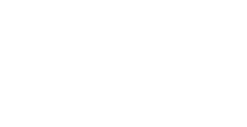Il mio DARFUR
DARFUR: MUORE ANCHE LA SPERANZA ?
Dall’alto, lo sterminato campo profughi di El Fasher sembra una città bombardata, come certe immagini di Hiroshima pochi giorni dopo l’atomica: muretti quadrati a perdita d’occhio senz’anima e senza tetti ma - mentre il C130 si abbassa verso la polverosa pista d’atterraggio - ti accorgi che quelle non sono rovine ma muretti a secco tirati su intorno a improvvisate capanne di paglia dove cominci a vedere un brulicare di persone.
Sono cinquantamila a vivere solo in quel campo, secondo le autorità dell’UN-OCHA che in qualche maniera cerca di tenerne almeno un conto di massima, ma è solo una piccola scheggia dei mille campi del Darfur dove a morire giorno dopo giorno è soprattutto la speranza.
“Alle 4 del pomeriggio i volontari se ne vanno – sussurrano i capi-villaggio raccolti a consiglio nei loro lunghi abiti bianchi – e noi viviamo nel buio e nel terrore, soggetti a violenze di ogni tipo”.
Non c’è sicurezza nei campi, né luce elettrica o fognature, ma a parte il cibo distribuito dalle Organizzazioni Internazionali soprattutto non c’è assolutamente nulla da fare per vivere in una brulla distesa di sabbia. Non un albero, pochi asini scheletriti, non un filo d’erba ed un caldo mortale. L’acqua è razionata: 32 litri per famiglia al giorno che nel diserto sono una goccia, ma soprattutto non c’è lavoro, un futuro, una possibilità. Gente che è qui da due o tre anni e ti guarda spiritata: “Fuori eravamo disperate, qui siamo prigioniere” sussurra una donna che non può uscire dal campo a rischio di violenze inaudite mentre i giovani non ci sono più, letteralmente spariti.
Ogni gruppo di famiglie ecco un recinto quadrato con un muretto tirato su con qualche frasca o qualche mattone cotto a mano intorno a un pugno di capanne di sterpi, coperte – chi ce l’ha - da una telo di plastica dove si riassumono i nomi delle associazioni d’aiuto di mezzo mondo. E’ l’unico elemento di colore in una distesa ocra senza fine, ma sono campi profughi diversi da quelli che ho visto in Rwanda o in altri parti dell’Africa: sembrano popolati da spiriti e il silenzio è totale, opprimente.
Si arrostisce di giorno e di notte si muore di freddo e va considerato che il campo di El Fasher è uno dei migliori, non fosse perche è a poca distanza dalla città e quindi virtualmente più sicuro dalle scorrerie dei Janjaweed, i “diavoli a cavallo”, le bande armate che per anni hanno scorazzato impunemente razziando ed uccidendo, evidentemente al soldo del governo di Kartoum e che spesso, muovendosi ancora a cavallo, attaccano e terrorizzano i villaggi. Per questo la gente scappa anche se a formale forza di difesa ci dovrebbe essere un contingente della Unione Africana (con soldati che non prendono paga da cinque mesi) con tante belle Toyota bianche allineate nel cortile, ma con regole di ingaggio tuttora incerte. Truppe sicuramente poco propense ad intervenire dopo che solo due mesi fa un paio di soldati sono stati uccisi – sgozzati - a pochi metri dalla stessa caserma, figurarsi andare in giro per un deserto magari di notte, dove non c’è un riferimento per centinaia di chilometri all’intorno.
E’ questa la realtà del Darfur, dove una popolazione che nel 1950 era di circa un milione di persone al confine tra Sudan e Ciad (si dice oggi salita a sei milioni, buona parte rifugiata o sfollata in Sudan, Ciad e nord dell’Uganda), è oggi in fuga dal nulla verso il nulla e con gli occhi pieni di paura e disperazione. Un conflitto originariamente tribale tra popolazioni nomadi e stanziali e poi politico e religioso, anche perché il clima è cambiato dopo la grande siccità degli anni ’80: la terra è diventata brulla sia per l’aumento della popolazione che per la guerra che ha devastato i villaggi e dove i pochi alberi che c’erano sono stati abbattuti. Un disastro umano ed ambientale che dicono essere numericamente la più grave catastrofe umanitaria di questi anni, ma in Africa è facile perdere il conto ed anche i dati sono a volte assurdi e contraddittori.
Di certo c’è solo che finalmente il Sudan ha accettato la presenza di una forza armata “ibrida” di 23.000 soldati ONU-Unione Africana che dovrebbe garantire la sicurezza, ma che – forse – verrà dispiegata solo tra qualche mese.
Strano paese il Sudan: è il più grande dell’ Africa ma, già spaccato in due nella guerra tra il sud animista e cristiano contro il nord musulmano, con ogni probabilità sarà scisso in due stati dopo un referendum previsto entro due anni. Un paese con un reddito di due dollari al giorno ma dove candidamente ti dicono che la popolazione è approssimata, come tutte le statiche. Teoricamente è ricchissimo per il petrolio e le materie prime ed ha un tasso di crescita stabilmente sopra il 10% l’anno, con una Kartoum assediata dalle auto e dai palazzi in costruzione. Ma proprio lo stabilire a chi appartenga il petrolio tra nord e sud (con un’industria estrattiva in gran parte in mano cinese e asiatica) crea divisioni profonde tra la classe dirigente che si riempie la bocca di pace e immancabili destini, ma appare soprattutto interessata a gestire ciascuno per conto suo la grande occasione delle royalties petrolifere e chiudendo un occhio su tutto il resto, diritti umani compresi.
Temporaneamente sospeso il conflitto al sud - che resta presidiato da truppe internazionali ( se il paese sarà diviso in due la capitale del sud, Juba, sarà l’unica capitale al mondo ancora senza energia elettrica e strade asfaltate) - ecco però scoppiare negli ultimi anni altri conflitti regionali all’est e nel nord-ovest del paese, in Darfur appunto, che reclama attenzione sostenendo che sia in atto di fatto un genocidio verso le tribù del deserto. Con reciprochi attacchi alla frontiera verso il Ciad, dove molti del Darfur si sono rifugiati, il Sudan ha rischiato anche di essere inserito tra i “paesi canaglia” secondo i servizi segreti americani per aver ospitato terroristi, ma in questi anni sembra essersi allontanato da un appoggio troppo spinto ai fanatismi islamici e dove, anzi, l’Islam sembra essere declinato, almeno formalmente, in modo più moderato. Un governo che viene considerato corresponsabile – a livello internazionale – per la destabilizzazione in Darfur, ma che si sta rendendo conto che non può più agire unilateralmente in una situazione che rischia di destabilizzare tutto il centro dell’Africa e quindi, anche per lo sfruttamento petrolifero, vorrebbe ora aprirsi anche alle compagnie occidentali. .
Tra contrapposizioni evidenti, gruppi ribelli che rifiutano le trattative, un parlamento per ora praticamente nominato e non eletto sarà lunga la strada per uscire dall’emergenza, anche se a Tripoli si sta per riunire – e sarebbe la prima volta – un conferenza internazionale sul Darfur presenti tredici paesi dell’area con Unione Europea (che ha stanziato 71 milioni di euro in aiuti umanitari) e Lega Araba tra gli invitati.
Geopolitica e discussioni che i dannati di Al Fashir e degli altri campi profughi non conosceranno mai, mentre un incredibile numero di bambini – come in tutti i paesi dell’Africa – trova comunque il modo di giocare tra la sabbia e ti saluta ridendo mentre sgommando in Toyota climatizzata scappi via, ma non riesci a dimenticare quegli occhi che ti hanno scrutato in silenzio sulle porte delle capanne, mentre già un’altra notte buia si avvicina.
Marco Zacchera