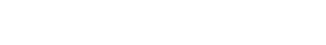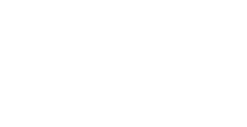I PICASASS
Interventi
I
PICASASS, DAL DUOMO ALLE COLONNE DI SAN PAOLO
Da
sempre l’estrazione della pietra è pane per il Verbano e l’Ossola dove da
secoli questa attività è economicamente una delle più rilevanti.
In
passato era spesso l’unica possibilità di lavoro – a parte un po’ di stentata
agricoltura sulle prime pendici dei monti – e generazioni di scalpellini hanno
lavorato duro - di solito morendo poi di
silicosi - nell’estrazione di
marmo, granito, serizzo e beole.
Pochi
conoscono nel dettaglio la storia di
alcune delle cave più famose e il lungo viaggio che, via acqua, veniva compiuto
per trasportare il materiale prima a valle e poi fino a Milano o a Roma.
IL
MARMO DI CANDOGLIA
La
cava più celebre di tutte è sicuramente quella del marmo di Candoglia con il
quale è stato realizzato il duomo di Milano.
E’
un filone particolare di marmo rosato che attraversa la base delle Alpi dalla
Valgrande ad Ivrea e che a Candoglia appare in superfice per riapparire poi ad
Ornavasso, sia pur con un materiale di minor qualità.
Le
prime estrazioni a Candoglia furono durante il periodo romano ma fu nel 1387
quando si prese la decisione di utilizzarlo per la costruzione e le finiture delle
guglie e delle statue del duomo di Milano.
Un lavoro immenso con i blocchi di marmo che venivano
calati a valle su slitte e scivoli di legno, imbarcati su chiatte giù per il
Toce e poi - per il Verbano , il Ticino ed i Navigli - giungeva fino alla
darsena di Sant’Eustorgio e da qui, con un sistema di chiuse, fino all’attuale
Via Laghetto, a poche decine di metri da Piazza del Duomo, nel centro della città.
Il duca Gian Galeazzo Visconti concesse anche delle
franchigie fiscali purchè sul materiale trasportato fossero chiaramente
impresse le indicazioni “ad usum Fabricae” (la “fabbrica” del Duomo) tanto che
i barcaioli, per entrare in città, utilizzavano una parola d’ordine: “AUF”,
l’abbreviazione appunto di “Ad usum
fabricae”, cioè ad uso della Fabbrica, con la quale i barconi potevano passare
senza pagare gabelle e pedaggio.
Da
qui nacque il termine “ad ufo” che nel
dialetto lombardo significa “gratuitamente” e senza pagare come “mangiare
ad ufo” ovvero senza far niente..
Il
marmo era prezioso ma scarso e le tecniche di estrazione del tempo obbligavano
a sciupare molto materiale che veniva a volte sostituito con quello di
un’analoga cava ancora visibile sopra
Ornavasso – continuità dello stesso filone – detto “marmo bastardo”. Oltre al
Duomo altre opere d’arte sono state realizzate con questo marmo come la Certosa
di Pavia e la Cappella Colleoni a Bergamo.
Oggi
la “Veneranda Fabbrica del Duomo” è l’unica autorizzata ad estrarre quanto
resta del filone originale (la “Cava Madre”) che viene utilizzato per
rimpiazzare le parti del Duomo rovinate dal tempo e dall’inquinamento.
Ancora con l’art. 1 del Decreto Legislativo n° 214 del 19
febbraio 1928, infatti, lo Stato Italiano ha confermato “[…] l’esistenza della servitù perpetua spettante
al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del monte di Candoglia di
scavare liberamente e gratuitamente i marmi e selci per uso della Fabbrica con
divieto di chicchessia di cavare, trasportare e vendere il materiale suddetto,
senza l’assenso dell’Ente stesso. È fatta eccezione solamente per il materiale
necessario alla costruzione e manutenzione degli edifici esistenti in loco”.
IL
GRANITO
Due
sono invece i tipi di granito più noti: quello rosa di Baveno e quello bianco
di Montorfano.
La storia del granito rosa di Baveno, detto in origine migliarolo,
è legata soprattutto alla famiglia Borromeo che iniziò ad utilizzare il granito
esportandolo a Milano dove si realizzarono i primi monumenti come il colonnato
del Lazzaretto (1506), la controfacciata del Duomo (1550), la chiesa di S.
Fedele (1570), il Seminario maggiore (1572), le logge del palazzo Brera (metà
del 1600) e - in anni più recenti - le eleganti colonne della Galleria Vittorio
Emanuele nel capoluogo lombardo.
Nel XVII secolo si utilizzò il granito rosa per il
grandioso piedistallo del San Carlone ad Arona e lo si ritrova in molti elementi
architettonici nel giardino barocco dell’isola Bella. Un granito oggi famoso
nel mondo visto che è servito per il palazzo reale di Bangkok e i monumenti a Cristoforo Colombo di New York e di Chicago.
All’inizio il materiale era ricavato usando i grandi “massi erratici” sparsi nella zona poi si
aprirono le “Pradere”, piccole
cave di fondovalle. Dal 1823 iniziarono le estrazioni da cave più grandi
occupando fino a 400 scalpellini.
Dal 1865, grazie a Nicola Della Casa, le cave di
Baveno si ampliarono ulteriormente, le tecniche di estrazione e lavorazione
vennero perfezionate e meccanizzate con l’introduzione del taglio a filo
elicoidale e la segatura meccanica.
Inizia anche l’uso delle prime grandi mine in galleria
che culminerà con l’esplosione della grande mina del 1890 che provocò un grande
squarcio sul versante del Monte Camoscio ai cui piedi vi è tuttora un
incredibile reticolo di strade e mulattiere che servivano a portare a valle il
materiale grazie a grandi carri tirati da buoi e cavalli.
Anche il granito bianco di Montorfano è “nato” come il
cugino di Baveno circa 280 milioni di anni fa. E’ però di
colore bianco e nero per la presenza di quarzo e feldspato mentre le sue
caratteristiche punteggiature nere derivano da una varietà di mica, ovvero di quel
gruppo di minerali tipico delle rocce di origine vulcanica. Questo materiale,
oltre a spiccare per eleganza, è molto
resistente alla compressione e agli agenti atmosferici per cui è indicato soprattutto
per la realizzazione di pavimentazioni
stradali, lastre, fontane, nella costruzione di edifici così e per l’arredo
urbano.
Il granito bianco di Mergozzo nel
2011 è entrato anche nel Guinness World Record grazie all’artista Giuseppe
Lusetti che nel 1997, dopo ben 8 lunghi e intensi mesi di lavoro, ha
miracolosamente ricavato da un unico blocco di pietra una catena composta da ben
239 anelli lunga quasi 30 metri, opera
che tutti possono ammirare presso
l’atelier dell’artista a Mergozzo.
Ma Montorfano è un granito
particolarmente adatto a realizzare colonne e le più note sono quelle della
basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, una delle quattro storiche
basiliche vaticane sorte dove la tradizione vuole sia stato martirizzato il
grande santo cristiano..
Ben 146 colonne, infatti, sono
partite dal Lago Maggiore verso la Città Eterna per un viaggio di oltre 2.200
chilometri che va sicuramente raccontato.
La Basilica di San Paolo era stata
realizzata nel 390 d.c. durante il regno di uno degli ultimi imperatori romani,
Valentiniano II, e nonostante terremoti, saccheggi, incendi e invasioni
barbariche rimase uno dei principali monumenti romani fino al 15 luglio 1923
quando- in una sola notte - venne
distrutta da un incendio.
Si trattò di ricostruirla secondo la
pianta originale vecchia di 1500 anni e nell’anno santo del 1825 papa Leone XII
annunciò la sua ricostruzione che si concluse nel 1854 con la benedizione di
Pio IX.
Si trattava di trovare però colonne
capaci di sostenere l’opera e servivanodi misure colossali: 11 metri di altezza e con una
circonferenza di 3.5 metri.
Le colonne necessarie erano 80, oltre
ad alcune ancora più grandi destinate a sostenere l’arco trionfale dell’abside,
cui si aggiunsero altre 64 colonne per il quadriportico di ingresso, dieci
delle quale realizzate in granito di
Baveno.
Le colonne – ciascuna del peso di
decine di tonnellate – furono man mano imbarcate su chiatte speciali direttamente
sulla riva del Toce discendendo poi verso il Naviglio Grande fino a Milano e di
qui a Pavia grazie al canale della Martesana e al Naviglio Pavese, arrivando così fino al Po.
Scendendo il fiume venivano
trasportate ad una ad una fino a Venezia
per essere imbarcate su due navi pontificie (la” Veloce” e la “Corriera”) che circumnavigavano l’Italia
passando per lo stretto di Messina e di qui fino ad Ostia dove venivano
trainate risalendo il Tevere.
Un viaggio lungo più di quattro
mesi e di 2.200 chilometri, percorso tutto
via d’acqua.
Ancora oggi è possibile ammirarle a
Roma, ma una di esse (la 147a) è rimasta
alla partenza perché giudicata non perfetta ed è tuttora visibile vicino alla
stazione ferroviaria di Verbania Pallanza, là dove era stata scavata.
LA BEATA GIOVANNINA
Queste grandi opere non devono però
far dimenticare che la gran parte del materiale estratto finiva per essere
utilizzato a scopi più semplici: gradini, selciati di strade, architravi e quindi
i blocchi venivano lavorati e scolpiti uno ad uno prima dell’imbarco sulle
chiatte.
Molte rive del Golfo Borromeo erano
quindi cantieri a cielo aperto come si possono vedere in tante foto dell’ ’800
e ancora in qualche punto vicino a Baveno.
Un lavoro duro cui erano chiamati
soprattutto i ragazzi e gli anziani, troppo deboli per i lavori di cava e di
trasporto. La polvere di silice creata dalla lavorazione con martello e
punte del marmo e del granito finiva però facilmente nei polmoni creando il
loro precoce invecchiamento e la silicosi era quindi la malattia professionale
del tempo, con morti causate dal progressivo soffocamento per insufficienza
polmonare.
Tantissimi erano gli scalpellini
della zona (molti emigravano all’estero e soprattutto in Francia, specializzati nella realizzazione
di lastre tombali) che soffrivano per questa malattia oltre che per la fatica
di un lavoro pesante.
Ad essi – così almeno dice la
leggenda – guardava con commiserazione e rispetto una donna di Suna di nome
Teodolinda ma che - si dice per la sua devozione a San Giovanni - era detta
“Giovannina”.
All’inizio del ‘900 aprì una
trattoria sul lungolago e - quando i clienti erano scalpellini poveri - pare rinforzasse i piatti in tavola a quegli
affamati.
Di qui il soprannome “la beata
Giovannina” che ancora oggi dà il nome a quella trattoria che nei decenni è
diventato un noto ristorante di
Verbania, sulla riva tra Suna e Fondotoce.
Marco Zacchera